
I Ritornanti. Storie di ritorni impossibili
I Fiori del web
Quello tra la vita e la morte è un percorso a senso unico. Oppure no? Cosa accadrebbe se il senso di marcia si invertisse, se i morti camminassero tra i vivi nelle mille forme che la letteratura fantastica ha dato loro finora? Zombie, vampiri, fantasmi, mummie… dieci revenant, o “ritornanti”, ognuno con la sua storia, i suoi conti in sospeso, il suo desiderio di beffare la morte, raggirarla, annullarne gli effetti. Dieci racconti di altrettanti autori, tra esordienti e veterani, che immaginano scenari differenti a partire da un solo tema: l’inversione del percorso, il ritorno dalla morte alla vita, con le sue grottesche e surreali conseguenze.

Niente fiori per San Valentino
I Fiori del Web
Piccoli racconti erotici nati sul web.
Una signora rimorchiata contro ogni sua aspettativa in una Roma assolata. Un amante che continua a distrarsi. Un brigante pugliese dagli enormi attributi, e tante altre storie.
In comune la capacitá di raccontare in maniera affascinante situazioni border-line e sicuramente hot.

100 domande sugli animali
In vendita nei maggiori eBook Store
oppure scarica gratuitamente 10 domande

Le favole di Fedro
Ragazzi Per Sempre | Favole
Dopo tanti mesi un nuovo “Ragazzi per Sempre”: Eccoci con una versione un po’ aulica delle favole di Fedro.
Fedro è uno scrittore latino. A inventare il genere era stato Esopo, ma quello che rende il genere famoso da noi è, appunto, Fedro che le riprende diversi secoli dopo.
Bisogna pensare che Fedro non vive in un periodo facile: Scrive i suoi libri durante l’ultimo periodo dell’impero di Tiberio e negli anni di Caligola. Erano momenti in cui a fare il moralista si aveva vita breve. Così Fedro, che pure vuol dire la sua, adotta come mezzo la favola: Chi se la prenderebbe con un autore che scrive testi per bambini? La storia non riporta che l’abbiano passato per le armi, quindi, probabilmente, l’espediente funzionò. Così, grazie al suo sviluppato istinto di sopravvivenza, produsse la più famosa raccolta di fiabe della letteratura.

Historytelling|Milano
Come sarebbe se, passeggiando per la città, potessimo conoscere le storie collegate a ciò che vediamo? Se invece di una didascalia o di un cartello segnaletico, potessimo leggere un racconto ambientato nel luogo che stiamo visitando? Come sarebbe se potessimo approcciarci ad un luogo storico attraverso gli occhi di qualcuno che quella storia la viveva come presente?HistoryTeller vuole andare in questa direzione. E’ una piccola raccolta di racconti e cronache di Milano, unita ad una ricerca iconografica che cerca di mostrare i posti di cui si parla com’erano al tempo della narrazione. In più, si appoggia al progetto Historyguerrilla, e quindi rende possibile scaricare via cellulare o tablet -attraverso un QR code- la parte di racconto relativa al luogo che si sta visitando.In un mondo sempre più crossmedia, cosa succede se uniamo il cartello segnaletico alla narrativa?
In vendita nei maggiori eBook Store
oppure scarica gratuitamente un racconto

Ricostituiamoci. La Costituzione italiana e le sue tre anime
Saggistica | Mezzilibri
Ricostituiamoci è uno straordinario viaggio dentro la genesi della nostra costituzione.
Giannella sceglie tre grandi padri costituenti, ciascuno interprete di una parte politica di allora, e gli fa raccontare le storie e i pensieri che hanno portato alla redazione della costituzione come la conosciamo adesso.
Così Nilde Iotti, Tina Anselmi e Giovanni Ferrara ci immergono in un racconto pieno di personaggi, aneddoti e grandi idee … e la Costituzione che siamo abituati a conoscere scompare per lasciare il posto a una grande avventura dove 75 persone si trovano con l’incredibile progetto di cambiare il proprio mondo, stabilendo le regole imprescindibili che dovranno consentire alla nostra nazione di crescere, senza mai più cadere in derive assolutiste.
E così fu.
In vendita nei maggiori eBook Store
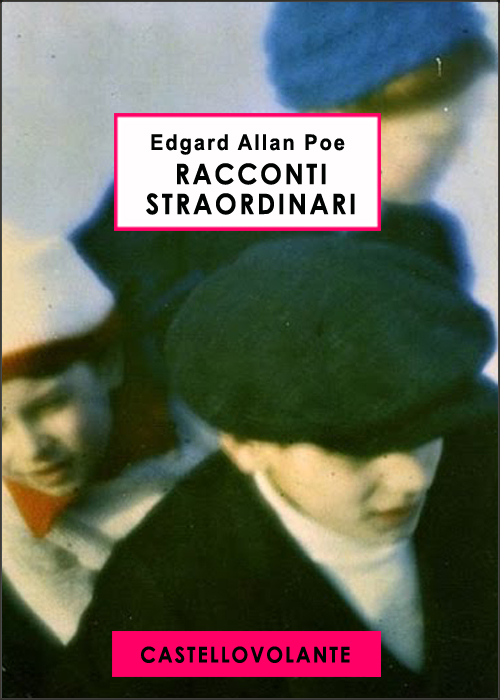
Racconti Straordinari
Semper | Grande Narrativa
Immortali, eterni, fantastici, meravigliosi. Chi non conosce i Racconti Straordinari di Poe? Lui li scrive e nasce un nuovo tipo di immaginario, una nuova forma di letteratura.
Lui, però, in quei mondi che creava ci viveva pure, come fosse personaggio della sua stessa fantasia. A leggere la sua biografia si ha l’impressione di una vita allucinata e angosciosa, sempre al limite della follia. I racconti li scrive durante tutta la sua vita produttiva cioé dai 26 ai 33 anni, morirà a 40. Si innamora in maniera intensissima di donne impossibili, amori sempre tragici. Prima la madre di un compagno di scuola, lei muore, lui ci mette un anno a riacquistare il senno. Poi una coetanea, la famiglia di lei lo bandisce, lui cade in depressione acuta. Infine la sua incredibile moglie, sua cugina. La sposa a 13 anni, a 19 lei si ammala di tubercolosi e lui praticamente smette di scrivere. A 23 lei muore e lui impazzisce. Due anni dopo muore pure lui.
Di tutta questa avventura umana rimane un romanzo (Le avventure di Gordon Pym) e i Racconti Straordinari.
Però hanno cambiato il mondo!

La pianta proibita. Canapa: coltura e cultura
Saggistica | Mezzilibri
La canapa è stata per secoli una delle risorse economiche, industriali e tessili più importanti del nostro Paese, secondo produttore mondiale per quantità ma primo per qualità. Nel Novecento, nonostante gli sforzi del fascismo di proteggere questo mercato, la canapicoltura è andata perduta. Questo saggio ne ripercorre la storia e analizza le cause del suo declino attraverso documenti inediti come un manoscritto di “materia medica” di fine Ottocento o le tavole dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert. Accanto alla storia dell’uso industriale di questa pianta oggi proibita, viene ripercorsa anche la storia del suo uso medico, riscoperto di recente, e di quello psicotropo, attraverso l’analisi di fonti come la leggenda di Marco Polo del Veglio della Montagna, a capo della setta degli Hashishiyya, da cui il termine assassino. E ancora, l’erba pantagruelione di Rabelais, il Poema dell’hashish di Baudelaire, le pagine del Conte di Montecristo di Dumas e quelle di Théophile Gautier. La storia del proibizionismo del Novecento viene ricostruita con un’analisi comparata con la proibizione di altre sostanze come il caffè, il tabacco e gli alcolici che hanno avuto come conseguenza la nascita dei monopòli di Stato e quella del gangsterismo. E un saggio sulla marijuana nella storia del cinema mette in luce come la considerazione della cannabis nell’opinione pubblica sia nel tempo cambiata: dalla droga devastante delle pellicole degli anni Trenta sino alle rappresentazioni leggere, scherzose e di denuncia del nuovo millennio.

FACEBOOK SCORIES [cronache di vita 2.0]
I Fiori del Web
18 brevi racconti irriverenti in cui il popolo della rete massacra il mito di Facebook! E il bello è che gli autori sono proprio coloro che lo utilizzano quotidianamente e quindi lo conoscono bene, anche nei suoi lati deteriori. I rapporti virtuali, dall’amicizia all’amore, sono messi alla berlina. I pericoli più inquietanti, dalla violazione della privacy ai rischi di dossieraggio o di essere vittime di attacchi di cybercriminali, sono evidenziati ed esasperati, spesso con ambientazioni fantascientifiche che dipingono un futuro allucinante, ma più che possibile. E poi il problema dei profili commemorativi post mortem, l’incubo di imbattersi in quei compagni di scuola poco graditi che se si erano persi di vista era perché c’erano molte ragioni, i problemi dell’Internet Addiction Disorder (IAD) e molto altro. Non solo narrativa, in sintesi. Non solo delle storie fresche, innovative e frutto dei nostri tempi. Ma anche uno spunto di riflessione intelligente sulla modernità e il tanto esaltato bisogno di condividere ogni cosa con tutti attraverso il più famigerato e pervasivo social network del cosiddetto web 2.0.

Immobile scuola. Alcune osservazioni per una discussione
Saggistica | Fuori collana
L’uomo del nuovo millennio è profondamente diverso da quello di primo Novecento. A dividerli, tra le tante cose, c’è il cinema, la radio, il telefono, la televisione, prima ancora del digitale e di Internet. Eppure alle spalle hanno lo stesso modello di scuola! I “nuovi media”, in realtà, non sono poi così nuovi, hanno almeno un trentennio. Il mondo accademico e della scuola, però, ha rifiutato il ben più complesso approccio multimediale e si è arroccato nella difesa di un modello chiuso che stride con quello che sta avvenendo ed è avvenuto nella società. La cultura non può più coincidere solo con la parola scritta e la stampa. Perché la rivoluzione del digitale e di Internet non ha coinvolto la scuola se non marginalmente? È ancora possibile trattare i saperi contemporanei che sono multimediali, complessi e aperti con rigidi schemi manualistici? Che cosa possono fare i singoli insegnanti in questo scenario ingessato da ragioni politiche ed economiche che li sovrastano?
Queste sono le domande che l’autore si pone in un inedito pamphlet che ha come obiettivo non solo l’individuazione delle risposte, ma soprattutto quello di generare una discussione aperta alle soluzioni da parte di tutti.
Roberto Maragliano, guru italiano della didattica con le nuove tecnologie, dopo essere stato professore a La Sapienza, è nell’organico dell’Università Roma Tre dove insegna “Tecnologie per la formazione degli adulti” e “Comunicazione di rete per l’apprendimento”. Le sue pubblicazioni: La scuola dei tre no, Laterza 2003; Parlare le immagini. Punti di vista, Apogeo 2008; Educare e comunicare. Spazi e azioni dei media (cura con Alberto Abruzzese), Mondadori Education, 2008; Adottare l’e-learning a scuola, Garamond-Bookliners 2011.

Il ritorno di Vasco e altri racconti dal carcere
Narrativa | Mezzilibri
Non è facile raccontare la vita del carcere con leggerezza e senza mai cadere nel pietismo o nei luoghi comuni. Su questo registro l’autore si muove con sapienza, ironia e semplicità. Del resto al carcere di San Vittore ha anche insegnato e conosce bene questo mondo che ha esperito.
Un clochard viene scambiato per Vasco Rossi da un gruppo di discotecari che lo raccattano dalla strada e lo ospitano. La vita gli cambia improvvisamente e per settimane viene nutrito e idolatrato dai fan. L’inevitabile finale sarà quello di finire in carcere, come si evince dal titolo che è il filo conduttore di questa raccolta.
Il marocchino Saachid, come in un film di Totò, in carcere ci va per sua decisione. Dietro le sbarre si dà da fare con mille traffici e lavoretti per racimolare piccole fortune. Scontata la pena torna al suo paese e fa il mecenate. Poi c’è Gabriel playboy colombiano che traffica con droga e gioielli per mantenere nel lusso le donne che frequenta. C’è Nello che ingoia lamette da barba per evitare il trasferimento e riuscire a prendere la licenza media e Matteo che si laurea a pieni voti a Porto Azzurro, combatte con il cancro e scrive un romanzo. E c’è ancora di più. Questo “ritorno” del Ritorno di Vasco, pubblicato per la prima volta da Marcos y Marcos nel 1994, include tre racconti inediti: “Gli amori di Irene”, “La grande farfalla” e “The in crowd”.
Davide Pinardi insegna al Politecnico di Milano e all’Accademia di Brera. Ha pubblicato numerosi libri di narrativa (La storia segreta del señor Correal, Rizzoli; Tutti i luoghi del mondo, Tropea; A Sud della Giustizia, Interno Giallo) e di saggistica (Narrare, dall’Odissea al mondo Ikea, Paginauno; Il mondo narrativo,Lindau; La Giubba del Re – Intervista sulla corruzione, Laterza; La letteratura Italiana tra ‘800 e ‘900, RCS).

Bastarde senza gloria
Saggistica | Mezzilibri
STORIE DI DONNE A VENEZIA DAL MEDIOEVO A PATTY PRAVO
Veronica Franco, la più celebre e celebrata meretrice veneziana del Cinquecento; Elena Lucrezia Corner Piscopia, la prima laureata della storia; Elisabetta Caminer la prima giornalista d’Italia; Rosalba Carriera, la più celebre ritrattista del Settecento; Sara Copio Sullam, la poetessa del ghetto
Margherita Sarfatti, l’amante ebrea di Mussolini che ha creato il mito del “dux” e ha collegato la romanità al fascismo; Patty Pravo, l’unica italiana ad aver venduto oltre cento milioni di dischi.
Sono vissute in epoche diverse, alcune sono cresciute libere, altre oppresse da società misogine; tutte queste donne, però, hanno un tratto in comune: sono nate a Venezia. Sono le veneziane che hanno segnato il loro tempo e spesso anche il futuro. Un eBook per restituire loro la fama che non hanno avuto. Per ribadire che l’Italia di oggi non è stata fatta solo dagli uomini, ma anche dalle donne.
Un titolo inedito di Alessandro Marzo Magno, veneziano, giornalista storico e scrittore, ha pubblicato numerosi libri, tra cui: Piave. Cronache di un fiume sacro (il Saggiatore 2010) e Atene 1687. Venezia, i turchi e la distruzione del Partenone (il Saggiatore 2011).

La divina suocera. Storia di Matidia che fece di Adriano un grande imperatore
Saggistica | Mezzilibri
L’incredibile storia di Matidia, la prima e unica suocera al mondo che sia stata addirittura divinizzata! Una delle più influenti matrone romane, nipote dell’imperatore Traiano, fu determinante nell’ascesa al trono di Roma da parte di Adriano che consigliava e seguiva persino nelle battaglie. La sua storia di madre, bisnonna e trisavola di imperatrici viene ricostruita in modo straordinario da una storica esperta nelle questioni femminili. Valeria Palumbo ha scritto questo libro in modo narrativo, con il risultato di rendere la sua rigorosa opera di divulgazione storica avvincente come un romanzo. L’autrice giornalista e caporedattore di L’Europeo ha pubblicato numerosi libri tra cui, Donne di Piacere (Sonzogno 2005), La perfidia delle donne (Sonzogno 2006), Svestite da uomo (Bur 2007) e Le figlie di Lilith (Odradek 2008) saggio sulla trasformazione del mito della femme fatale in diva. Il libro L’ora delle Ragazze Alpha (Fermento 2009) sulla terza onda del femminismo, ha vinto il premio selezione Anguillara Sabazia 2010. Il presente eBook è stato pubblicato per la prima volta nel 2004 dalla casa editrice Selene e ristampato nel 2010 con alcune revisioni.

Opere da tre clic [antologia della blogosfera]
I Fiori del Web
Una selezione dalla blogosfera che ripropone nove autori di scritture divertenti, imprevedibili e soprattutto brevi, di quelle che si leggono in soli tre clic. Perché la lettura a monitor costringe al dono della sintesi. Non si tratta necessariamente di blogger famosi e noti al “grande pubblico” della rete, ma di scrittori apprezzati da un piccola cerchia di estimatori. Questo, infatti, è il senso dell’operazione di scouting che vogliamo riproporre. Sono storie che in alcuni casi hanno la forma del racconto, in altri possiedono invece una loro continuità e lasciano intravedere una trama, oltre che uno stile omogeneo nella scrittura. Sono storie per tutti i gusti scelte per dimostrare che sul web si possono leggere anche pezzi molto interessanti e di buon livello. In alcuni casi meglio di quel che non è affatto gratis e si pubblica sulla carta abbattendo gli alberi.

Ti faccio un thriller [mini-gialli da una pagina a un tweet]
I Fiori del Web
Contro la prolissità dilagante di certe pubblicazioni il cui numero di pagine genera volumi così pesanti da poter diventare l’arma del delitto, il popolo della rete si sfida nella produzione di gialli che hanno come obiettivo la brevità, alla ricerca del dono della sintesi decantata persino da Calvino nelle Lezioni americane. Dai gialli di una pagina, o poco più, sino a quelli che si possono inviare in un sms e addirittura in un tweet, che ricordano certi Delitti esemplari di Max Aub e a cui hanno partecipato, divertiti, anche scrittori e giallisti affermati.

e-PERQUENAU? [rifacimenti di stile]
I Fiori del Web
È il rifacimento in versione web degli Esercizi di stile di Raymond Queneau. Una selezione delle migliori variazioni sul tema raccolte in un gioco che per quasi due anni si è svolto su un blog, premiato al concorso Scrittura Mutante e oggetto di una pubblicazione. Una galleria di interpretazioni non solo retoriche ma anche poetiche, ludiche, automatiche, grafiche. Componimenti che sfiorano il falso letterario, a volte molto colti, spesso divertenti, in molti casi raccontati da punti di vista assolutamente imprevedibili. L’intelligenza collettiva, per dirla con Pierre Levy, connessa in rete, si è cimentata con il più classico dei libri gioco con dei risultati sorprendenti.

Vite da precari [tra creatività e follia]
I Fiori del Web
Il tema del precariato è ormai epocale e molto sentito. Nato da un gioco-concorso sviluppato sul primo «blog opificio di sperimentazione letteraria» italiano, l’eBook raccoglie una quarantina di brevissimi racconti ironici, pungenti, fantasiosi e assurdi. Senza mai cadere nel patetico e nel banale, queste storie precarie scritte da precari costituiscono un divertente spaccato di chi è costretto a [soprav]vivere costantemente in bilico tra la creatività necessaria all’invenzione di un lavoro e il rischio della follia.

Novelle per un Anno – volume 3
Semper | Grande Narrativa
Finalmente! Si pubblica oggi la terza parte delle Novelle per un anno…ora possiamo finalmente sapere esattamente quante sono… beh, in questo volume abbiamo raccolto tutte quelle che Pirandello aveva inserito nella sua Appendice perchè precedentemente accantonate…chissà poi per quale motivo…noi le abbiamo trovate una più bella dell’altra!
Godetevele!
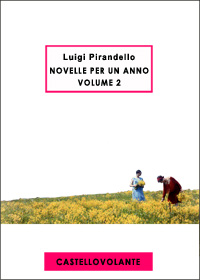
Novelle per un Anno – volume 2
Semper | Grande Narrativa
Ecco il volume 2 della monumentale raccolta di Pirandello! Altre ottanta novelle per la vostra libreria digitale e per i vostri weekend di primavera. Ma non finische qui: di volumi, alla fine, ce ne sarà un’altro ancora, con l'”Appendice”: tutte le novelle che gli erano “rimaste sparse”.
Buona lettura!

Novelle per un Anno – volume 1
Semper | Grande Narrativa
Tutti conosciamo qualcuna delle Novelle per un Anno, ma avete veramente idea di quante siano sul serio? Beh, per farvi un’idea, il primo dei due volumi ne contiene 120. Quindi potete stare sicuri che ne troverete tantissime che non avete mai letto e nemmeno sentito da lontano.

Prospettive Fiabesche di Macchine Rare
Reincontri | Steampunk
Essere steampunk é una questione di spirito, bisogna essere modernisti, ma anche immaginifici e gotici. Potevamo quindi non comprendere nella nostra antologia trasversale anche testi futuristi? Ecco allora un Depero perso e affascinato tra auto fiabesche, come lui stesso le definisce. Un pezzetto di letteratura di genere decisamente imperdibile.
Anche in questo caso il merito di aver trovato e pubblicato il libro per la prima volta é di Stampa Alternativa. Ma noi l’abbiamo rieditato!

Il Fu Mattia Pascal
Semper | Grande Narrativa
Chi non ha pensato almeno una volta di sparire e e cominciare da capo? Il caso di Mattia Pascal è più intrigante: al culmine di una vicenda familiare pessima, pesante e pietosa sparisce, adesso diremmo va a comprare le sigarette.
Subito però gira la fortuna e, nel giro di pochi giorni diventa ricco e contemporaneamente scopre di essere stato identificato con un’altro trovato morto: Mattia Pascal viene così sbalzato dal proprio destino dentro un’altra identità che lui battezza Adriano Meis.
AM è benestante, viaggia, si innamora. Insomma, ha una vita tanto brillante quanto quella di Mattia Pascal era meschina. Eppure alla fine si ritrova vecchio, a vivere nello stesso piccolo paese di Pascal, facendo lo stesso lavoro da bibliotecario e andandosi a trovare al cimitero.
Un’immagine quest’ultima che da sola vale il nobel che per’altro Piirandelllo s’è preso.

Le Meraviglie del 2000
Reincontri | Steampunk
Visto che il genere steampunk ha riscosso notevole successo, ecco un’altra perla: L’unico romanzo di fantascienza di Salgari.
Due amici, un ricco giovane ed un medico geniale, usano un rimedio sconosciuto per risvegliarsi dopo cento anni: Riaprono gli occhi in un fantastico 2003 a base di elettricità, rivolte di anarchici e macchine volanti.
Enjoy it

Anna Karenina
Semper | Grande Narrativa Le famiglie felici si somigliano sempre l'una con l'altra: ogni famiglia infelice lo é in un modo particolare :) Se sapeste quanta fatica abbiamo fatto per rendere disponibile Anna Karenina in epub-free e quanto ne siamo orgogliosi, capireste che é puro amore! AK é il primo libro da cui partiamo direttamente dal cartaceo, questo ci ha costretto a dimezzare la frequenza di uscita. Ve ne sarete accorti, da due libri a settimana siamo passati ad uno. Ecco quindi il nostro attuale programma editoriale: uscire circa una volta al mese, ma con un grande libro! E adesso immergetevi pure :)

I Sette Capelli d’Oro della Fata Gusmara
Ragazzi per Sempre | Fiabe
Quando Salgari scriveva del Corsaro Nero o di Sandokan in Italia c’era un’altra scrittrice altrettato fertile (in senso letterario, naturalmente), la pessima Carolina Invernizio che a noi piace tanto.
Qui, per una volta, si cimenta in una fiaba per ragazzi. Come sempre, Carolina tira dritto e si fa degli schemi suoi, infischiandosene abbastanza di quelle che sono le consuetudini letterarie dell’epoca. Ed ha un grande successo, E produce una quantità impressionante di libri. E vende tantissimo. Ed è pure donna!
Insomma, abbastanza per fare imbestialire i pomposi letterati suoi contemporanei. Di cui lei, per l’appunto, non si curava per nulla.
E volete che non ci sia simpatica?
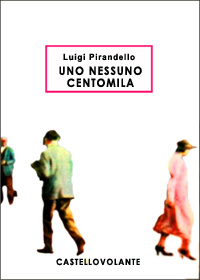
Uno Nessuno Centomila
Semper | Grande Narrativa
Naturalmente tutto parte dal naso del protagonista che secondo la moglie pende da un lato. E dalla infinita concatenazione di pensieri che da lì lo portano fino alla pazzia. Mai dar retta alle mogli!
Come ci vedranno gli altri? Come saremo veramente da fuori? Tutti ci pensiamo, Vitangelo però (che naturalmente è il protagonista del libro e non il vostro portinaio) ha il coraggio di provare a sostenere il suo vero io contro le proprie immagini. Naturalmente non ci riesce, si inimica tutti, combina diversi casini e alla fine viene dichiarato pazzo. E allora finalmente riesce ad essere libero e in fondo anche felice.
Però c’è un trucco: tutto questo, prima che Pirandello scrivesse Uno Nessuno Centomila non era mai stato scritto.
Ecco perchè Pirandello è Pirandello.

La coscienza di Zeno
Semper| Grande Narrativa
Con La coscienza di Zeno iniziamo una nuova serie di Semper: la grande narrativa. Avete presente quei ibri che tranquillizza avere vicino? Quelli che, sia che li abbiate letti oppure che dobbiate ancora leggerli, dovete assolutamente avere a disposizione? Quelli che siete sempre certi che da un momento all’altro inizierete a leggere? E che quando finalmente aprite vi rendono felici?
Beh! quelli li!
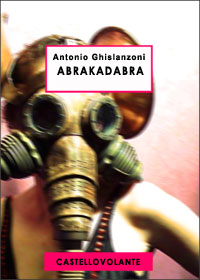
Abrakadabra
Reincontri | Steampunk
Dunque, già il fatto che Ghislanzoni – il librettista dell’Aida – scrivesse un romanzo di fantascienza ambientato nella Milano nel 1982 è di per sé surreale. Se a questo aggiungete tratti di preveggenza da far venire i brividi (“a quell’epoca – parlo del 1977 – l’Unione Europea era un fatto compiuto“), fantastiche macchine steampunk, e un immaginario romantico-scapigliato degno appunto del principale librettista verdiano, avrete l’idea del più improbabile (e un po’ sconclusionato) romanzo che certamente l’800 ha prodotto.
Dimenticavamo: il tutto introdotto da un bel racconto-prologo, che è in realtà la storia romanzata del ritiro di Ghislanzoni in montagna e della decisione di scrivere il libro.
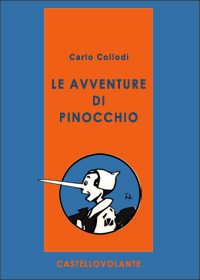
Le avventure di Pinocchio
Ragazzi per Sempre | Racconti
Pinocchio è talmente famoso che a tutti sembra di conoscerlo. Ma non è mica tanto vero! Sapevate che Collodi (che non si chiamava affatto Collodi ma Lorenzini) lo scrive in due volte e che inizialmente non intendeva scrivere un racconto per bambini? Infatti la prima versione finisce con l’impiccagione di Pinocchio! Poi il romanzo esce a puntate nel Giornale per ragazzi e quasi raddoppia e si arricchisce di personaggi e situazioni sempre più fantasmagoriche e irreali. Tanto che Pinocchio finisce per assomigliare al fratellino un po’ sfigato di Alice. Ovviamente il finale della storia è un “tantino” diverso…

Dizionarietto Rompitascabile degli Editori Italiani
Pensiero Fossile |
Il libro è semplice: un elenco di tutti gli editori italiani del 1928, con un piccolo commento per ciascuno. Eppure è un libro bellissimo. Formiggini, è uno di quei personaggi che scompaiono dalla storia, ma che poi, quando si rincontrano per caso sono luminosi. Infine, la nostra riedizione è ripresa da una precedente fatta nel 2004 da Stampa Alternativa. E’ loro il merito di aver ripubblicato il Dizionarietto. Nostro è solo quello di riproporlo. Tra l’altro CastelloVolante non esisterebbe se noi, nel 2004, non avessimo per caso letto il loro Formiggini.
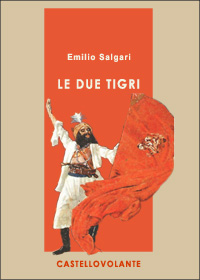
Le due Tigri
Ragazzi per Sempre| Avventura
Dopo aver imperversato nel Borneo, il duo Sandokan-Tremal-Naik si prende una vacanza in India. Si sa, gli eroi son gente abitudinaria: fanciulle da salvare (in questo caso la figlia dell’indiano), appassionanti cacce ai cattivi (qui il capo dei Thugs, arrivato da Bolzano)…insomma, atti inutili di eroismo masochista. CastelloVolante con questo chiude la parentesi Salgari, sempre che non ci sia una rivoluzione da parte dei fedelissimi!!!

Don Chisciotte della Mancia
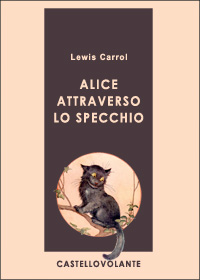
Alice attraverso lo Specchio
Ragazzi per Sempre | Racconti
Il secondo libro di Alice prende le mosse sei mesi dopo che Alice è tornata a Casa. Un pomeriggio sta sonnecchiando in salotto quando si chiede cosa c’è dall’altra parte dello specchio e … ci passa attraverso, come in Matrix. Poi si ritrova nuovamente nel paese delle meraviglie logiche e dei nonsense …
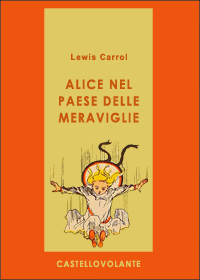
Alice nel Paese delle Meraviglie

Entusiasmi
Reincontri | Roberto Sacchetti
Le cinque giornate di Milano nel più bel romanzo scritto su quei giorni.
Trent’anni dopo le 5 giornate, un giovane scrive un romanzo sulla rivolta. Sacchetti era stato con Garibaldi in Tirolo, poi diventa giornalista e scrittore. E’ uno scapigliato e un rivoluzionario, a Milano dirige il Pungolo – il giornale dell’avanguardia -, ha fonti di prima mano, ha cose da dire. Avrà destino tragico: a 32 anni, mentre scrive questo libro, muore. Lo dicono gli editori nella prefazione.
E voi pensate di leggere Il Cimitero di Praga ?
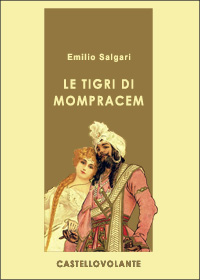
Le Tigri di Mompracem
Ragazzi per Sempre | Avventura
Aaah! orrendo errore: Le Tigri di Mompracem viene prima dei Pirati della Malesia. Abbiamo sbagliato l’ordine di pubbblicazione!
E’ il terribile karma delle Tigri!
Lo sapete che con questo romanzo inizia la triste storia di Emilio Salgari? Con Le Tigri di Mompracem Salgari divenne finalmente famoso … e si ritrovò, per sempre, costretto a scrivere un numero costante di pagine al giorno, avendo appena di che mantenere la famiglia. Durò 28 anni, scrisse 88 libri, finché un giorno non ne poté veramente più e, come in un libro scritto male, si suicidò facendo harakiri. Per davvero: si sventrò alla maniera dei samurai, col rasoio. Incazzatissimo.
Nelle lettere, lasciò scuse verso i figli e insulti verso gli editori. E’ il karma! è il karma!
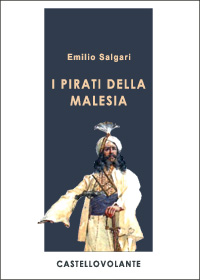
I Pirati della Malesia
Ragazzi per Sempre | Avventura
Kammamuri va a liberare il suo padrone Tremal-Naik e … naufraga a Mompracem dove incontra Sandokan e Yanez. Così la Jungla confluisce nei Pirati, e Inizia il ciclo d’avventura più appassionante di tutto l’800.
Diciamo subito che – a meno che non raggiungiamo il milione di richieste – non avremo la dedizione di pubblicare tutti i 13 libri che compongono la serie, ma almeno i primi sì.
W Sandokan!

Il Ventre di Napoli
Pensiero Fossile | Prima della Storia
Matilde Serao era sempre stata decisamente bruttina, anche da giovane. Tozza e sgraziata, rideva in maniera grossolana e aveva l’aria troppo semplice per i salotti eleganti e in più era anche ragionevolmente priva di mezzi. Però Matilde scrive. Collabora con decine di riviste, fonda giornali e diventa il primo direttore donna, in un’Italia in cui le donne non avevano alcun diritto. Così, a metà della sua vita, nonostante l’aspetto ordinario e una certa bonomia di carattere, è già diventata un’interlocutrice primaria della vita politica e sociale italiana.
Il Ventre di Napoli nasce come una lettera a De Pretis, allora capo del governo. Una cronaca che vuole mostrare l’altra Napoli, quella vera e fuori dalle cronache del colore locale. Quello che ne esce è un’affresco indimenticabile e terribilmente moderno.
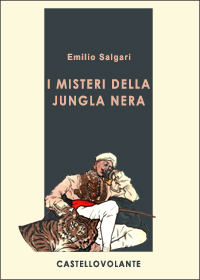
I Misteri della Jungla Nera
Ragazzi per Sempre | Avventura
Chi si ricorda ancora della Dea Kali e dei suoi Thugs? Non erano schifidi angiolotti paffuti prodotti a Bolzano, ma mortali killer che strangolavano con un laccio di seta, rapivano fanciulle e adoravano la loro mortalissima dea dalle molte braccia.
Leggete questo libro. Ucciderete un soprammobile kitsch! E speriamo che l’anima di Salgari non legga mai questa recensione.
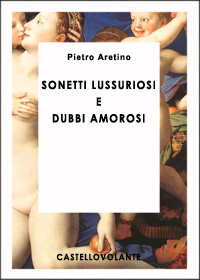
Sonetti Lussuriosi e Dubbi Amorosi
Semper |
E’ chiaro che il politically correct ci fa obbrobrio, e quindi non potevamo che pubblicare Pietro Aretino.
Ma voi li avete mai letti Sonetti e Dubbi? Sono moooolto peggio di quel che pensate, così pessimi da meritarsi di passare alla storia per il loro pessimismo.
E quindi nei Semper

Jolanda la Figlia del Corsaro Nero
Ragazzi per Sempre | Avventura
Tranquilli il Corsaro Nero è morto. Dopo aver finalmente ritrovato la sua amata, lei rimane incinta e – naturalmente- muore di parto. E lui finalmente smette di soffrire lasciandosi uccidere sulle alpi. Amen. Qui e’ di scena la figlia, molto piu’ vivace e simpatica del padre, assieme a Morgan l’ex secondo del Corsaro, per altro vero personaggio storico. Assieme alla riconquista del patrimonio del Corsaro e dei Wan Stiller.
Buona Befana!
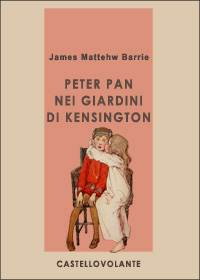
Peter Pan nei Giardini di Kensington
Ragazzi per Sempre | Racconti
Beh! in realtà Barrie scrive più di un libro di Peter Pan, e questo è quello senza Wendy in cui Peter, piccolo, abita tra le fate nei Giardini di Kensington.
Certo, il libro è scritto prevedendo dei bambini che ascoltano, ma, in mancanza di materia prima, si possono ottenere buoni risultati anche col fidanzato/a mentre fuori nevica.
Oppure al gatto!
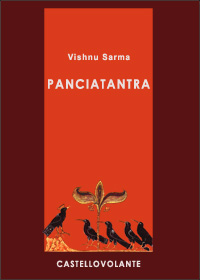
Panciatantra
Ragazzi per Sempre | Favole
Chiudiamo l’anno con poesia!
Un po’ Favole di Esopo, un po’ Mille e Una Notte, Panciatantra è un antico libro indiano di fiabe. Strepitosamente sconosciuto, poetico come solo le grandi favole sanno essere, interpretato quasi interamente da animali.
Insomma, quello che ci vuole per cominciare con serenità un anno che sarà certamente bellissimo!
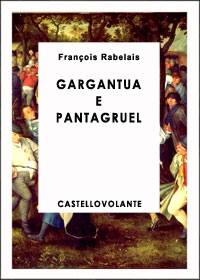
Gargantua e Pantagruel
Semper |
Avete mai letto il Gargantua?
“C’è molta crudezza, violenza e un umorismo che fa uso delle funzioni corporali“, dice Wikipedia, con un tono da signorina scandalizzata.
Diciamo che, mentre da noi Ariosto componeva un grande poema cavalleresco, in Francia Rabelais inventava la gara di rutti: Potevamo perdercelo?
Insomma, se non l’avete letto è ovvio che ora lo leggerete. E se invece lo conoscete non potrete fare a meno di appropriavene.

Le Mille e una Notte
Ragazzi per Sempre | Favole
Mille anni fa qualcuno decise che era ora di scrivere il più bel libro di tutti i tempi. Per prima cosa cominciò a raccogliere tutte le storie più belle. Trovò storie moderne e antichissime, egiziane, persiane, iraniane, insomma, un po’ di tutto.
Ma poteva bastare? Sai che noia un’antologia ragionata della favola orientale? Così eran capaci tutti!
No! Doveva essere il libro più bello del mondo!
E qui ebbe un’intuizione fantastica e si mise a scrivere una favola lui stesso. E questa favola era piena di personaggi che raccontavano favole a loro volta, e le loro favole contenevano persone che raccontavano, e così via.
Adesso per sapere come finiva una storia dovevi iniziarne un’altra e cosi via fin che eri alla fine del libro.
Così nacque il libro più bello di tutti i tempi.
Buon Natale!

La Regina dei Caraibi
Ragazzi per Sempre | Avventura
Corsaro Nero II° episoido.
Il bello delle serie è che quando uno comincia poi deve andare avanti. E quindi eccoci di nuovo alle prese con i nostri soliti eroi: Wan Stiller, Carmaux, Moko e il Corsaro Nero, sfigatissimo in amore come sempre. Però, questa volta, arriva un lieto fine da manuale.
Meno male che nel terzo episodio il Corsaro Nero è morto :)

La Trovatella di Milano
RosaLimone | Milano
Finalmente un’altro RosaLimone!
Gli intrighi di Carolina Invernizio non hanno certo nulla da invidiare alle nostre novelas contemporanee. In più, però, hanno il fascino di essere ambientate (e quasi scritte) a ridosso dell’unica parte gloriosa del nostro passato. E di essere, a modo loro, certamente femministe.
Un rosa che ormai è una lettura impegnata!
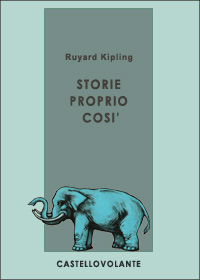
Storie proprio così
Ragazzi per Sempre | Favole
Voi lo sapete perchè l’elefante ha il naso lunghissimo, il cammello ha la gobba, il Leopardo ha le macchie e come fu scritta la prima lettera?
Certo che lo sapete! Ma solo perché qualcuno vi ha letto questo libro quando eravate piccoli.. nel lettone!
E adesso tocca a voi perpetuare la conoscenza.
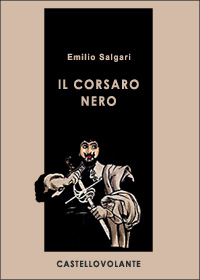
Il Corsaro Nero
Ragazzi per Sempre | Avventura
Wan Stiller, Carmaux, il nero Moko, il perfido duca Van Guld, la bellissima Honorata, e il pallidissimo, coraggiosissimo, fatalissimo, invincibilissimo – e in effetti fichissimo – Corsaro Nero.
Non li avete dimenticati Vero?
Ora sono di nuovo con voi!

I Promessi Sposi

Canto di Natale
Ragazzi per Sempre | Racconti
Siete afflitti da allergia del Natale? Vorreste gia’ essere a meta’ gennaio? Il pensiero dei prossimi festeggiamenti vi sconforta? Allora beccatevi la nostra Strenna Natalizia: Il Canto di Natale di Dickens!
E vedrete che, assieme a quelli dell’orrendo signor Scooge, anche i vostri occhi saranno aperti dagli spettri natalizi, e diventerete piu’ buoni.
Ah! la letteratura.

Apologia di Socrate
Semper |
Questa collana potrebbe chiamarsi “bagagli per il diluvio”.
Quante decine di milioni di vite avrà influenzato la lettura dell’Apologia ? A partire da Platone – che come prima opera della sua vita sentì il bisogno di raccontare la morte del suo maestro – la bellissima storia della morte di Socrate non ha mai smesso di essere parte della vita di tutte le generazioni dell’occidente.
Si capisce che amiamo questo libro vero?

Orlando Furioso
Semper |
Certo, per leggere in versi – al giorno d’oggi – ci vuole un fisico bestiale! Però l’Orlando merita. Intanto è tutto composto da microstorie che si rincorrono, ma che sono anche autosufficienti … e così già passa subito la paura da Grande Tomazzone Scolastico. Poi ci si accorge subito che è stato scritto per esser letto a voce alta e per divertire. E così, appena ci si immerge nella lettura, è tutto un fiorire di immagini folgoranti e fascinose. Così, quello che rimane impresso, è che – terminato di leggere – vi sembra di averlo visto, anziché letto.
Una specie di protocinema!

Racconti
Assolutamente da non perdere.
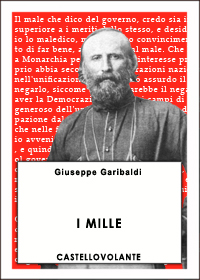
I Mille
Pensiero Fossile | Prima della Storia
Garibaldi è un rivoluzionario e un idealista, il suo pensiero, lontanissimo dall’essere conciliante, è violento e veemente. Le cose che dice, potrebbero esser state scritte oggi, tanto sono attuali. Niente di più lontano dalla figura addomesticata che la storia scolastica ci ha passato.
Ci hanno abituato a un Garibaldi personaggio a margine, un po’ folkloristico – con la sua indiscipina e il suo poncho – ma che comunque, in maniera in fondo borghesemente rassicurante “obbedisce”. I Mille non è un bel libro – sinceramente Garibaldi scrive da cani – non scorre d’un fiato, ma è un libro indimenticabile. Dopo non vedrete più le cose con gli stessi occhi. E questo è il compito della letteratura.
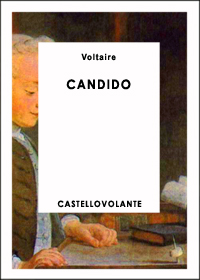
Candido
Semper |
Se, da 250 anni il Candido è un successo editoriale, un motivo ci sarà pure! L’ironia leggera di Voltaire – per quanto secolare – non può fare a meno di farci sorridere, e le vicende del candidissimo Candido sono innegabilmente divertenti. E così, stupiti noi stessi di poter trovare spassosi gli accidenti orrendi cui vanno soggetti i poveri eroi del libro, li seguiamo per tutta europa e diamo agio a Voltaire di poter filosoficamente sberleffare tutti i miti di un 700 meno luminoso di quello che vorrebbe farci credere.

Farfui
RosaLimone | Milano
Nell’anno 1901 gli archetipi della milanesità erano già tutti lì: l’agente di borsa, l’industriale quarantenne che si è fatto da sé, la moglie di famiglia borghese …solo un secolo prima. Farfui è un bel romanzo di Zuccoli, un po’ rosa ma non troppo, sicuramente godibile, di quei libri che si va avanti a leggere per sapere come vanno a finire.

I Fioretti di San Francesco
Semper |
In un’Italia del 1200, le storie – un po’ peripezie, un po’ parabole – dela vita di San Francesco.
Cinquantatre piccoli racconti, scritti in un volgare che riesce ad essere poetico e spassoso nello stesso tempo. Uno stile linerare e semplice accompagna un pensiero candido, quasi leggero.
Insomma, anche se nulla vi cale della vita dei santi, i Fioretti sono un libro bellissimo e affascinante.
E poi mentre lo si legge si ha sempre un’impressione, come se in fondo – di fianco alla esemplarietà delle storie – potesse far capolino, da un momento all’altro, il comico.
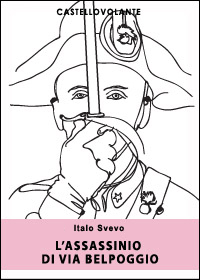
L’assassinio di via Belpoggio
RosaLimone | Trieste
Il libro raccoglie tre racconti lunghi di Svevo: “L’assassinio di Via Belpoggio”, “Lo specifico del dottor Menghi” e “Vino generoso”.
Letteratura popolare alla maniera di Svevo: storie leggere attraverso la narrazione soggettiva di ciascuno dei tre protagonisti. Tre vite implicate in delitti, incubi e fantascoperte, fermate dall’occhio chirurgico dell’autore.
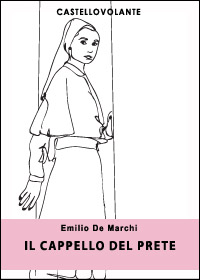
Il Cappello del Prete
RosaLimone | Napoli
Il Cappello del Prete, nella letteratura italiana, è noto come il primo romanzo del genere che poi diverrà il “giallo”.
In una Napoli post-garibaldina ma pre-unitaria, si muovono i personaggi indimenticabili di questo noir ante-litteram. Protagonisti un barone in rovina, con un recente passato garibaldino, nichilista e libertino, ora “pitocco disperato”, e un parroco usuraio, afflitto dalla dote singolare di indovinare i numeri del lotto. Un intreccio avvincente in una Napoli slendida e vivida fine di secolo.
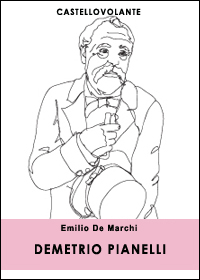
Demetrio Pianelli
RosaLimone | Milano
Le vicende della famiglia Pianelli, in una sorta di affresco rosa-noir. Vizi, disgrazie economiche, amori, morti e redenzioni in una Milano fin de siecle di piccoli funzionari alle prese con la vita di ogni giorno.
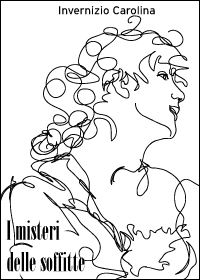
I Misteri delle Soffitte
RosaLimone | Milano
Milano: la notte di un movimentato giovedì grasso. Una misteriosa giovane signora, con una bellissima maschera segue uno studente fin dentro la soffitta dove vive. E lì assistono alla scena di un delitto.
Con lo stile tipico di Carolina Invernizio, la trama immediatamente si intreccia attraverso equivoci, tradimenti e segreti insvelabili. Fino al giusto trionfo dell’Amore.

Guerra in Tempo di Bagni
Vassallo, scrive un rosa che è un capolavoro di leggerezza spensierata. Lazzi cavallereschi, corteggiamenti e burle, in questa duello tra un anziano ammiraglio e il giovane nobile pretendente della figlia, naturalmente osteggiato.
Fa da sfondo una sorprendente Livorno balneare a ridosso dell’Unità d’Italia, quando la capitale era … Firenze.
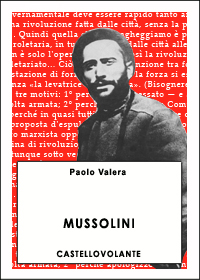
Mussolini
Pensiero Fossile | Prima della Storia
1919 Mussolini ha 36 anni, e inizia la critica del socialismo. La storia deve ancora essere scritta. Il Fascismo non è ancora nato, Mussolini è un socialista che sta diventando popolare per le sue posizioni barricadere.
Come avviene oggi, Paolo Valera – cronista socialista e collega – decide di scriverne una biografia che faccia conoscere meglio il personaggio…

Fine d’Anno
Reincontri | Paola Drigo
Una giovane vedova si trasferisce in campagna per cercare di amministrare direttamente i suoi possedimenti e porre rimedio al dissesto economico in cui si è venuta a trovare. Si dovrà confrontare con l’impenetrabilità del mondo contadino e l’invalicabilità della differenza sociale.
Un romanzo lucido, completamente privo di luoghi comuni. Un sorprendente verismo al femminile ambientato in veneto nelle campagne dell’alto Brenta.

Maria Zef
Reincontri | Paola Drigo
La condizione femmile e la campagna friulana sono al centro anche di questo romanzo della Drigo.
Maria Zef è una piccola ambulante che l’autrice segue dai dodici anni ai venti facendo un affresco della realtà contadina di inzio secolo.
Narrando la storia di Maria, la Drigo rappresenta, senza celebrarla, la difficoltà di essere donne sole in un mondo maschile, proponendo però un modello di donna mai passivo e rassegnato verso quanto la circonda.

Il Milione
Semper |
Anno Domini 1298. Marco Polo è rinchiuso in una prigione genovese assieme a Rustichello da Pisa, un letterato che ha girato Francia e Inghiterra, e ha portato per primo in italia il ciclo arturiano. E’ così che Marco decide di dettare la memoria di suoi viaggi, intrapresi tra il 1275 e il 1295.
Nasce Il Milione, la storia di un incredibile viaggio di andata e di riorno ciascuno durato oltre tre anni e della permanenza di 17 anni in Catai alla corte del Gran Khan.

Il Decamerone
Semper |
Dieci giovani, dieci giornate, cento novelle.
E’ il 1349, la peste è appena passata da Firenze quando Boccaccio inizia a scrivere il Decameron. Probabilmente lo scopo era mostrare come lo spirito non si facesse abbattere dalle traversie, o forse divertire un po’ in un momento che doveva apparire ben nero. Il risultato più evidente fu una raccolta di storie così divertenti e scanzonate da attraversare l’europa per quasi sette secoli, influendo sulla storia e sulla cultura dell’intero occidente.









